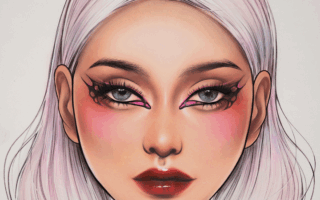Il vero ago della bilancia. Chi guarda, ascolta, commenta, clicca, compra. Chi premia o penalizza, a seconda di ciò che sceglie di seguire.
Il pubblico.
Ed è proprio qui che la questione si fa più delicata.
Spesso è il pubblico stesso a chiedere — più o meno consapevolmente — contenuti rapidi, leggeri, che si lascino consumare in un attimo. Più breve è il video, meglio è. Più virale è il prodotto, meglio è. Più il linguaggio è semplice, caricaturale, semplificato all’osso, più funziona.
Poi però ci si lamenta dell’assenza di profondità, ignorando regolarmente chi prova a offrirla. Si critica la monotonia dei contenuti, ma si continua a cliccare sempre sugli stessi volti.
La verità è che l’attenzione media si è ridotta a una manciata di secondi. I contenuti devono essere già masticati, pronti da ingoiare, rassicuranti. Se un video supera il minuto, si salta. Se una caption invita alla riflessione, si scrolla. Se un creator mostra competenza, viene archiviato come noioso.
L’algoritmo, in tutto questo, non è il colpevole: è solo uno specchio. Riflette ciò che riceve. Se i contenuti più superficiali ottengono più attenzione, più like, più commenti, la colpa non è dell’intelligenza artificiale. È nostra.
Non è un problema di leggerezza in sé. Ironia, informalità, spontaneità sono strumenti meravigliosi, se usati bene. Il problema è che stiamo disimparando a pensare. A distinguere. A porci domande. A premiare chi porta valore, anche nel beauty.
Eppure, questi fenomeni non sono nulla di nuovo. Già negli anni passati le persone sono state attratte dalle celebrità, ma ciò che cambia oggi è l’accessibilità: non è più necessario essere un attore famoso o una rockstar per acquisire popolarità e guadagnare milioni. Oggi chiunque può diventare famoso attraverso una foto su Instagram o un video su TikTok, ma a un prezzo molto più alto: l’immagine che ci si è costruiti. E il pubblico, spesso inconsapevolmente, diventa complice di questo meccanismo.
Uno degli aspetti più affascinanti (e insieme inquietanti) della cultura degli influencer è la capacità di riscrivere i desideri del pubblico. In molti casi non ci limitiamo a osservare: partecipiamo. Non solo guardiamo i contenuti, ma li imitiamo, li eleviamo, e in certi casi cerchiamo di replicarli, magari sperando di ottenere lo stesso successo. È un processo subdolo, che non passa sempre dalla consapevolezza, ma dalla continua esposizione a modelli di vita perfetti, apparentemente facili.
E non è nemmeno una novità. Anche in passato si idolatravano le celebrità, la differenza è che oggi la celebrità sembra essere alla portata di tutti. Non serve più una carriera, uno studio, un talento specifico. Bastano una foto fatta bene un video fatto bene, un algoritmo compiacente e il prodotto giusto da mostrare.
Il prezzo da pagare è quello dell’identità. E il pubblico, troppo spesso, finisce per esserne complice.
Ma cosa spinge milioni di persone a seguire qualcuno, spesso senza porsi domande sulla veridicità o sul reale valore di ciò che gli viene mostrato?
Il termine “pecora” viene usato spesso per definire chi segue la massa senza porsi domande. Ed è brutale, sì, ma in molti casi tristemente realistico. Si osservano influencer come si guarderebbe un reality: con distacco apparente, ma coinvolgimento totale. Il problema è che più questi modelli si ripetono, più perdiamo di vista i nostri desideri reali. Ogni trend seguito, ogni prodotto acquistato “perché lo usano tutti”, è un passo in più verso la perdita di individualità.
Non posso sapere cosa spinga ognuno ad agire in un certo modo, ma è probabile che alla radice ci siano bisogni umani semplici e universali.
Uno su tutti? La curiosità.
La voglia di guardare la vita perfetta di qualcun altro, di sbirciare dietro il vetro. Una curiosità che un tempo si placava con un pettegolezzo tra amici e che oggi, invece, si è trasformata in numeri da capogiro sui social. Gli influencer (alcuni, perlomeno) non mostrano semplicemente momenti di vita, ma mettono in scena veri e propri copioni. Storie confezionate per piacere. Per vendere. Per intrattenere. E più ci crediamo, più perdiamo il senso delle cose.
Questa idealizzazione porta a credere che esista un unico modo giusto per vivere, apparire, truccarsi, vestirsi. Così, nel tentativo di appartenere, finiamo per uniformarci.
Qui si apre un altro capitolo fondamentale: il bisogno di sentirsi accettati, inclusi, parte di qualcosa. I like, i commenti, le condivisioni sono la linfa di questo ecosistema, ma quando il pubblico smette di farsi domande, il sistema smette anche di evolversi. L’influencer diventa una presenza totalizzante, quasi un punto di riferimento assoluto, e il pubblico lo segue come se stesse seguendo la mappa per la felicità. Ma chi sta davvero tracciando quel percorso? Siamo noi a decidere dove andare o ci stiamo solo lasciando trasportare?
Il mondo del beauty è molto più di una palette ben fotografata o di un codice sconto. È narrazione, estetica, cultura visiva. È un linguaggio che possiamo ancora scegliere di esplorare con criterio. Okay, non sarà fisica quantistica, ma richiede almeno di accendere il cervello prima di aprire il portafoglio. Pensare non va più di moda, ma almeno è gratis.
Non basta più mostrare, bisogna ragionare. Non basta più copiare, serve selezionare.
Soprattutto, ricordiamoci che c’è sempre una possibilità di scelta: fermiamoci, ogni tanto, e chiediamoci se stiamo guardando qualcosa di autentico o solo una vetrina ben allestita, e per quale cazzo di motivo.
Anche se la strada è lunga, ogni piccolo passo verso la consapevolezza è già un bel cambiamento.
Per chiudere, mi sento di spezzare una piccola lancia in favore di quella parte di pubblico che i neuroni li usa.
Spesso sento affermazioni come: “se continui a guardare qualcosa che non ti piace, allora sotto sotto ti piace”, oppure “se critichi qualcosa che non ti piace sei solo ipocrita”, o anche “se il video non ti piace, nessuno ti costringe a guardarlo, se quella persona non ti piace non sei costretto a seguirla”. Tutti cugini del famoso “chi critica, lo fa solo perché prova invidia”, “no critike sl complimenti”.
Posto che credo fortemente che un conto sia esporsi con un commento (magari cafone, maleducato, fuori luogo) e un conto esprimere un parere, direi che guardare o seguire anche cose che non piacciono non è affatto sempre sinonimo di approvazione. Basti pensare ad altri settori come la politica, lo sport, ma anche realtà più vicine a noi (la banca, l’ospedale, i negozi… sono tutti luoghi in cui si svolge un lavoro, dopotutto).
A volte osserviamo per capire, per analizzare, per difenderci, per mettere in discussione. Dire che l’unico motivo per cui si continua a guardare è il “piacere” (o addirittura l’ossessione) è ridurre la complessità umana a un click compulsivo.
Questo pensiero, inoltre, solleva chi produce contenuti da ogni tipo di responsabilità: se qualcosa fosse tossico, fuorviante, dannoso? Eh, allora basta non guardarlo. Ma così si normalizza l’idea che chi parla ha sempre ragione, e chi ascolta deve solo scegliere se spegnere o accettare in silenzio. No grazie, non fa per me.
Il colpo di scena finale: “ti piace sentirti inferiore”. Ecco il gaslighting bello e pronto. Se critichi, sei tu il problema. Se provi fastidio, è perché sei insicuro, rosicone, frustrato. Così chi solleva dubbi viene ridicolizzato e chi crea contenuti si blinda in un ego impermeabile alla realtà. Ma la libertà di espressione vale anche per chi analizza, critica, riflette, o solo per queste persone qui? Non è odio, almeno nel mio caso, è pensiero. E il pensiero, abiamo già detto, fa bene. Le critiche costruttive non servono soltanto agli altri, a volte bisognerebbe farsi un esame di coscienza.
Se tutto quello che non ci convince lo avessimo ignorato e basta, nessun cambiamento nella storia sarebbe mai avvenuto. Quindi no, non smetto di guardare. Continuo a guardare proprio perché mi interessa capire – e, se necessario, dire la mia (educatamente).