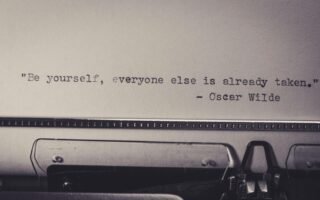Nel magico mondo della bellezza online, dove tutto luccica e non esistono baby hair fuori posto, le aziende cosmetiche si muovono come fate madrine. Incantano con packaging scintillanti e campagne perfettamente orchestrate, ma basta scostare un po’ il velo dell’apparenza per accorgersi che dietro quel sorriso da spot pubblicitario anni cinquanta si nasconde spesso una realtà molto meno glamour.
Sì, perché se i brand sanno essere accoglienti con chi li celebra pubblicamente o li tagga con cuoricini e faccine, la musica cambia (e pure in fretta) quando si parla di servizio clienti, trasparenza o semplicemente… disponibilità. Alcuni si comportano come se esistessero solo per i follower con le spunte blu, mentre i comuni mortali – cioè noi povery – restano nel limbo dei messaggi lasciati in visualizzato, delle domande ignorate e delle risposte automatiche che sembrano scritte da un tostapane.
Voglio proprio parlare di questo, del divario tra l’immagine curata che i brand proiettano online e del modo in cui gestiscono davvero la relazione con le persone; se davvero il cliente viene prima di tutto, allora forse è il caso di guardarsi bene allo specchio. Ma stavolta, senza filtri.
Durante il lancio di un nuovo brand beauty o di un nuovo prodotto si crea un’atmosfera quasi mistica, misteriosa. Una palette dai toni mai visti prima, un claim che promette miracoli… E poi… magia! I pacchetti iniziano ad arrivare, ma non bussano a tutte le porte. No, quei nastri dorati e quelle PR box perfettamente instagrammabili sembrano conoscere una sola strada: quella che porta sempre alle stesse mani, agli stessi feed, alle stesse caption. È così più o meno dal 2010 e non solo in Italia.
Una sorta di rituale. Cambia il nome del marchio, il concept della collezione, talvolta la nazione di provenienza. Ma i volti, pardon, i profili? Quelli no. Restano sempre gli stessi. Le “prescelte”, le “storiche”, le “già note al sistema”. Anche se il brand è appena nato e il pubblico ancora non lo conosce (salutiamo gli indie brand), i nomi che lo accompagnano sono familiari come il detergente viso nelle morning routine. I peggiori forse sono quei marchi già affermati che, appena sbarcano sui social con la versione italiana della loro pagina ufficiale, iniziano subito a collaborare con i soliti nomi. Creator che, fino al giorno prima, non solo non avevano mai mostrato interesse per quei prodotti, ma magari li avevano pure criticati apertamente e in malo modo (per non parlare dei decluttering con la scusa del “faccio spazio”, “non fa per me”, “lo regalo”, salvo poi miracolosamente riscoprirne la qualità non appena arriva la collaborazione).
Una sorta di beauty élite, una rosa ristretta di influencer che ricevono ogni novità, spesso in anteprima e spesso ignorando il significato della parola “tempismo”.
Figure magari professionali, o davvero appassionate in alcuni casi, che però rappresentano solo una fetta (non troppo variegata) del panorama reale. Non so tu, ma io non mi sento rappresentata quasi da nessuno. Mi sembra di vivere dentro a un televisore che trasmette i film tra una pubblicità e l’altra (a volte dichiarata, a volte meno).
A volte mi chiedo se sto guardando un video diverso o sempre lo stesso: le nuove leve sembrano uscite tutte dallo stesso stampino, parlano alla stessa velocità, con lo stesso tono entusiasta, le stesse espressioni. Faccio fatica a distinguerle, anche perché sono tantissime, figuriamoci a fidarmi. E ogni santa volta che sento qualcuno dire “amo” rivolgendosi a degli sconosciuti, anche tramite lo schermo del telefono, spengo tutto.
La realtà è che molte aziende, anche le più giovani, non scelgono chi le rappresenta in base all’affinità reale con il brand: spesso si affidano alle agenzie o alle stesse liste trite e ritrite, per “giocare sul sicuro”. Il risultato? Una comunicazione omologata, dove la novità si veste di déjà vu e il prodotto si fonde nel rumore di mille altri.
Le micro-influencer? Le creator indipendenti? Quelle che magari testano davvero tutto prima di parlarne? Spesso restano invisibili. Non per demerito, ma per mancanza di “connessioni”. Perché in questo mondo, l’engagement è importante… ma le conoscenze lo sono ancora di più.
Oggi il principale parametro di valutazione non è più la creatività o l’autenticità di un influencer, ma esclusivamente i numeri, i profitti e l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Le aziende, sempre più focalizzate su risultati rapidi e misurabili, preferiscono collaborare con influencer che vantano un grande seguito, indipendentemente dal valore che effettivamente possono offrire in termini di originalità o pensiero critico.
Questa corsa al profitto e alla visibilità a breve termine ha creato una spirale in cui i contenuti sono sempre più simili tra loro, mirando tutti a soddisfare le stesse aspettative di engagement. Gli influencer, a loro volta, si sentono spinti a seguire questi modelli “sicuri” per non rischiare di essere esclusi dalle partnership più lucrative. Così, l’individualità e la creatività rischiano di essere messe da parte, sostituite da formule già collaudate che portano a numeri altissimi, sebbene a discapito di una proposta veramente originale. In un contesto del genere, è facile capire come influencer giovani e promettenti possano essere “nascosti” o, peggio, non riuscire mai a farsi strada, se non si allineano con i desideri delle grandi aziende e la logica del profitto immediato.
Tutto questo approccio porta a una conseguenza inevitabile: l’appiattimento. Non si fa più informazione, si fa vetrina.
Nell’ultimo periodo stanno prendendo piede UGC creator e ECG (o ECC, le commesse che fanno video, insomma), e devo dire che provo sentimenti contrastanti pure nei loro confronti: se da un lato rappresentano una boccata d’aria fresca rispetto ai soliti influencer, dall’altro generano dinamiche che non sono sempre così limpide.
Il lato interessante è senza dubbio l’apparente autenticità: per esempio, vedere una ragazza che lavora in un negozio mostrare i prodotti, spiegare le promo, rispondere alle domande nei commenti, può far sentire il pubblico più vicino al brand. C’è qualcosa di rassicurante nell’idea che non stai guardando l’ennesimo reel preconfezionato, bensì una persona “normale” che fa il suo lavoro e ci mette anche la faccia. In certi casi si crea addirittura un rapporto quasi affettivo: si va nel negozio perché c’è lei, quella che hai visto su TikTok. Si acquista quel prodotto perché l’ha consigliato una con cui hai affinità e di cui pensi di poterti fidare, ed è bellissimo.
Eppure, non sempre è tutto così genuino come sembra. Questi contenuti non nascono nel vuoto: spesso sono parte di strategie aziendali ben precise, con linee guida, approvazioni, e in alcuni casi veri e propri copioni (o brief) da seguire. Non sono video “casuali”, anche quando vogliono sembrarlo. L’UGC non sta solo condividendo il suo entusiasmo: sta facendo un lavoro aggiuntivo per il quale, spesso, non è nemmeno retribuita in modo equo. Alcune aziende premiano la visibilità, ma non necessariamente con un riconoscimento economico. E altre magari la danno per scontata, come fosse un’estensione “naturale” del contratto.
Poi c’è l’ambiguità del linguaggio. Spesso i contenuti scivolano nei cliché menzionati in precedenza: il prodotto “pazzesco”, l’evento “imperdibile”, la promo “da prendere al volo”. Nonostante la faccia diversa, il messaggio resta identico a quello degli spot classici, solo che si fa riferimento a brand diversi e meno noti. E quando i toni sono troppo entusiasti, troppo forzati, si rischia l’effetto contrario: lo spettatore si accorge della recita e scatta la diffidenza. La spontaneità, quando è spinta troppo, diventa artefatta. E si vede.
Un altro elemento critico è che questa esposizione mediatica, in fondo, serve prima di tutto all’azienda. È il brand a guadagnarci in termini di visibilità, fiducia e conversioni. Chi ci mette la faccia, invece, si espone a commenti, critiche, e talvolta anche a conseguenze spiacevoli. Non è raro che queste figure, diventate improvvisamente “popolari”, si trovino a gestire situazioni per cui non erano preparate.
Quando è davvero sentito, quando nasce da una passione reale o da un rapporto sano tra lavoratore e brand, può creare connessioni potenti.
Alla fine, quello che vediamo sui social — che sia un influencer, una commessa o una “ragazza della porta accanto” — resta comunque una forma di comunicazione pensata per vendere. E se ci illudiamo che basti cambiare il volto del messaggio per renderlo più onesto, forse dovremmo iniziare a chiederci chi ne beneficia davvero.
In questo gioco al ribasso, a rimetterci sono tutti: le aziende, che perdono autenticità; i consumatori, che si fidano sempre meno; e le voci nuove, che non trovano spazio.
Forse è il momento di fare come Daenerys e spezzare la ruota (non che a lei sia andata benissimo…), di premiare il contenuto vero, quello che nasce da passione e non da contratto. Di restituire al beauty la sua parte più bella: la diversità. Quella vera, fatta di visi nuovi, punti di vista alternativi e parole che non sembrano copiate da un comunicato stampa.
Attenzione, con ciò non intendo dire che alcuni pilastri del settore debbano essere demoliti: anche loro svolgono un ruolo importante nell’orientare il pubblico e nel creare fiducia nei confronti di determinati brand o prodotti. Questi influencer non sono solo “nomi famosi”, ma veri e propri punti di riferimento per la loro audience, l’ho già detto, che li segue non solo per le loro competenze, ma anche per il valore che riescono a trasmettere attraverso i contenuti.
La loro capacità di generare fiducia è un aspetto che non va sottovalutato. Sono persone che, attraverso anni di esperienza, sono riuscite a costruire una relazione di lunga durata con il loro pubblico, diventando un faro di affidabilità in un mondo spesso bombardato da influencer più giovani e/o meno esperti/capaci. Il loro impatto va ben oltre la semplice promozione di prodotti: sono in grado di educare i consumatori, di fare scelte consapevoli e di proporre idee innovative che possono guidare l’intero settore verso un’evoluzione positiva.
Tutto chiaro? Non si tratta di abbattere queste figure di riferimento, ma di ampliare la prospettiva e far emergere una pluralità di voci che possano arricchire il panorama, senza escludere chi ha già consolidato la propria posizione nel settore.
Insomma, la relazione tra aziende e chi fa contenuti è una danza elegante fatta di regole non dette, aspettative implicite e ruoli ben assegnati. Le aziende decidono chi “merita” visibilità, chi riceve i codici, chi può accedere agli eventi, e chi invece resterà per sempre un numero nel database. Altro che meritocrazia: la visibilità non si conquista, si eredita.
Codici, link e fumo negli occhi: decifrare il linguaggio delle aziende
Prima di proseguire, dato che non tutti ne sono al corrente, sarebbe il caso di soffermarci brevemente sulle varie modalità usate da aziende, influencer e affini (me compresa) per (cercare di) monetizzare online.
🔁 Referral: ti porto un’amica, tu mi regali 5 euro
Il referral è il più “innocente” tra i sistemi. Una persona condivide un link o un codice che permette a un’altra di iscriversi o fare un acquisto. In cambio, entrambi ricevono qualcosa: uno sconto, un buono, magari un mini prodotto. È una strategia win-win, ma molto utile per i brand che in questo modo acquisiscono nuovi clienti con pochissimo sforzo. Una sorta di passaparola fra amici.
💸 Codice sconto non affiliato: “vi regalo il 10%” (ma non guadagno nulla)
Spesso si tratta di un codice fornito direttamente dall’azienda, senza che ci sia un ritorno economico per chi lo condivide. In apparenza, serve solo a “fare un favore” alla community, ma per il brand è oro: ottiene pubblicità gratuita, acquisti tracciabili, e può valutare l’efficacia promozionale della persona che lo condivide. Il pubblico pensa: “Che carina, ci fa risparmiare!”, ma è anche un modo per l’azienda di monitorare chi converte di più… per eventuali future collaborazioni più interessanti.
💰 Codice sconto affiliato: tu compri, io guadagno
Questo è il codice che genera una commissione per chi lo condivide. In pratica, è una mini affiliazione: ogni volta che qualcuno lo usa, l’influencer riceve una percentuale (di solito piccola: tra il 5% e il 15%). Pochi dichiarano esplicitamente che è un affiliate link, o che stanno guadagnando da ogni acquisto. E qui le aziende non solo sono complici, spesso sono loro a suggerire di non specificarlo troppo. Meglio un “Se vi va, usatelo 💕”, così sembra una cosa casuale e disinteressata.
🤝 Affiliazione vera e propria: la partnership che non si vede
C’è poi il livello superiore: quando l’influencer è parte di un programma strutturato di affiliazione. Questo spesso include:
-
link tracciati,
-
dashboard con vendite e guadagni,
-
contratti veri e propri con scadenze, obiettivi e percentuali concordate.
In questo caso si parla di collaborazione economica vera, anche se il pubblico non sempre lo capisce. L’influencer continua a parlare del prodotto come se fosse frutto di una “scoperta personale”, anche se dietro c’è un rapporto di lavoro formalizzato. Tali contenuti andrebbero marcati come ADV.
🎁 Gifted: il limbo tra la pubblicità e la recensione
Un altro grande classico: i prodotti “regalati”. Quante volte abbiamo sentito dire “ho ricevuto questo da…” oppure “ho avuto l’opportunità di provare quest’altro”?
Inviare gifted a chi ha una community attiva è un investimento a basso costo con alto potenziale di visibilità. Normalmente non ci sono vincoli particolari e si ha la possibilità di non parlare di un prodotto se proprio non è piaciuto.
Nonostante questo, le aziende si aspettano qualcosa in cambio, raramente si tratta di piacere nel far provare quel prodotto a quella persona. Anche solo una buona parola, un tag, o meglio ancora: una recensione.
Quando il brand diventa snob: customer care da favola (cattiva)
C’è un aspetto dei brand beauty e dei negozi online che raramente viene affrontato con onestà, forse perché tocca un nervo scoperto: il modo in cui si relazionano con il pubblico. Non quello da milioni di follower, ma quello reale, quello che acquista, attende, spera in una risposta.
Hai un problema con un ordine? Scrivici!
Mandi un DM? Un’email? Lasci un commento sotto il post? Speri in un minimo di attenzione? Silenzio. O peggio: ti arriva la risposta automatica con emoji inclusa, proprio come fanno corrieri e compagnie telefoniche da anni.
Nel frattempo, sotto lo stesso post, qualcuno con il badge blu scrive: “Wow, non vedo l’ora di provare tutto! 😍” e… magia! Risposta in meno di 5 minuti, con tanto di cuoricini e magari un invito alla prossima presentazione.
Al massimo ti arriva una risposta passivo-aggressiva del tipo “Grazie per il tuo feedback, prenderemo in considerazione”. Le faremo sapere.
Il problema è che molti brand non parlano davvero con i consumatori, parlano solo tra loro. Influencer, PR, creator con il numeretto giusto. Il resto è rumore di fondo. E così il servizio clienti diventa un decoro, una formalità, un muro di gomma.
Anche in questo caso, mi ripeto all’infinito, non sono tutti uguali né si tratta di un comportamento che dipende dalla grandezza del brand. Anche in contesti più piccoli c’è chi ti tratta male, convinto che non ne parlerai mai, che non ti crederà nessuno perché non sei conosciuto, e così via.
A volte non rispondono nemmeno quando compri e hai un problema concreto. Tempi di consegna eterni? Prodotto danneggiato? Campioncini promessi e mai arrivati? Non importa. Hai provato a scrivere via email, su Instagram, in piccione viaggiatore. Niente. Ma se avessi scritto: “Adoro la vostra nuova collezione 💖” ti avrebbero detto “Grazie tesoro! Stay tuned 💋”.
I peggiori, quindi il 90% di quelli con cui ho avuto a che fare io, anche di recente, sono quelli che non leggono neanche quello che scrivi, per non dire che non lo capiscono. Esempio pratico: se ti dico che ho dovuto mandare un pacco a un fermopoint, è inutile rispondere che è disponibile per il ritiro, te l’ho appena detto io! Risolvimi il problema, piuttosto.
È la versione beauty dell’alta società digitale. Si risponde ai complimenti, ma mai alle domande. Si interagisce solo se puoi portare engagement. I brand ti trattano come fan, non come cliente. Anzi, come follower, come un gregge di pecore nell’ovile.
E se ti permetti di fare una critica – anche garbata – rischi di venire ignorata, shadowbannata o cancellata. Oggi la customer care passa dalla moderazione dei commenti e dalla selezione di chi è degno di risposta.
E allora viene da chiedersi: a chi parlano davvero i brand oggi? A chi si rivolgono? A chi li paga o a chi li promuove?